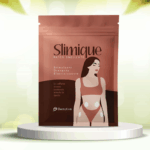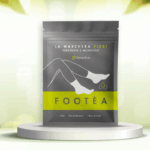In Italia l’ictus cerebrale rappresenta una delle principali cause di morte e disabilità, delineando ogni anno un quadro epidemiologico estremamente complesso e delicato. I dati ufficiali confermano che si tratta di una delle prime due cause di decesso nel nostro Paese — insieme alle patologie ischemiche del cuore — e costituisce la prima causa assoluta di invalidità permanente nella popolazione adulta. Ogni anno, infatti, si registrano circa 90.000 ricoveri per ictus cerebrale, di cui il 20% sono recidive: questi numeri evidenziano una realtà drammatica che influisce profondamente sulla vita dei pazienti, delle loro famiglie e sull’intero sistema sanitario nazionale.
L’impatto immediato: mortalità e sopravvivenza nel breve termine
Analizzando la fase acuta dell’evento vascolare, le statistiche mostrano che tra il 20% e il 30% delle persone colpite da ictus cerebrale non sopravvive al primo mese. I dati italiani sono coerenti con le osservazioni a livello europeo ed internazionale: nei primi 28-30 giorni successivi all’ictus, il rischio di morte resta elevato, e il decesso avviene sia per danno cerebrale diretto sia per complicanze organiche secondarie, come infezioni o scompenso metabolico.
L’età avanzata rappresenta un fattore aggravante, poiché il rischio di ictus e, di conseguenza, anche la probabilità di mortalità aumentano in modo esponenziale dopo i 65 anni. In particolare, il 75% degli episodi si verifica oltre questa età. Tuttavia, se si supera questa fase critica, le possibilità di sopravvivenza migliorano, ma si devono comunque considerare significative ricadute sulla qualità della vita.
Dopo il primo anno: sopravvivenza, disabilità e qualità della vita
Superata la fase acuta, la mortalità a distanza di un anno rimane alta: tra il 40% e il 50% dei pazienti colpiti da ictus muore entro i primi dodici mesi. Questo dato, pur in leggera diminuzione negli ultimi decenni grazie alle migliori strategie di prevenzione e terapia, riflette ancora una realtà preoccupante. Le probabilità di morte per chi ha avuto un ictus nell’ultimo anno risultano cinque volte superiori rispetto a chi non ha mai subìto un evento simile.
Solo una minoranza dei sopravvissuti riesce a recuperare pienamente le proprie capacità: circa il 25% dei pazienti torna a una qualità di vita paragonabile a quella precedente all’ictus. Il restante 75% rimane con una qualche forma di disabilità; tra questi, circa la metà manifesta deficit così gravi da perdere l’autosufficienza e necessita quindi di assistenza continuativa per le attività quotidiane. Le disabilità possono variare dalla perdita di mobilità alla difficoltà di linguaggio, passando per disturbi cognitivi ed emotivi come ansia e depressione persistenti.
Sopravvivenza nel medio-lungo termine: aspettativa di vita e recidive
Valutare l’aspettativa di vita dopo un ictus significa considerare sia il rischio di morte precoce sia la probabilità di insorgenza di nuove complicanze. Uno studio danese di riferimento mostra come, per chi supera il primo anno dopo l’ictus, la durata media di sopravvivenza resti comunque nettamente inferiore rispetto alla popolazione generale della stessa età. In media, la vita dopo un ictus risulta “dimezzata”: solo circa il 31% dei pazienti supera i cinque anni dall’evento, soprattutto in caso di ictus ischemico (la forma più comune, che rappresenta circa l’85% dei casi ).
- Nei pazienti sotto i 50 anni colpiti da emorragia cerebrale, la sopravvivenza raggiunge il 57%.
- Negli over 70, la sopravvivenza cala drasticamente, con appena il 9% dei pazienti vivi a distanza di alcuni anni.
Inoltre, il rischio di recidiva nei sopravvissuti è significativo: circa un quinto degli ictus rilevati ogni anno sono recidive, che presentano un rischio ancora maggiore di esiti fatali o d’invalidità grave.
Il percorso del paziente: riabilitazione, autonomia e impatto sociale
Per quei pazienti che sopravvivono, la fase successiva all’ictus coinvolge spesso un intenso percorso di riabilitazione, che può durare da alcune settimane a diversi mesi. I risultati della riabilitazione sono estremamente eterogenei e dipendono da numerosi fattori, tra cui:
- Gravità dell’evento acuto e tempestività dell’intervento terapeutico.
- Età, stato di salute generale e comorbilità preesistenti.
- Supporto familiare e sociale, accesso a centri di neuroriabilitazione specializzati.
La qualità della vita dopo un ictus non si misura solo in anni “vissuti”, ma anche nel grado di autonomia residua. Secondo studi basati su scala di valutazione della disabilità (come la Modified Rankin Scale), il pieno recupero si osserva in circa 1 paziente su 4; gli altri sviluppano disabilità più o meno gravi, che includono problemi di mobilità, di cura personale e di svolgimento delle attività quotidiane. L’entità della disabilità è quantificata nei vari stadi: dalla lieve (difficoltà nelle attività abituali) alla severa (grave limitazione nella deambulazione, necessità di assistenza continua e presenza di dolore cronico o disturbi psichici persistenti).
Sul piano sociale, le conseguenze dell’ictus pesano non solo per il paziente, ma anche per i suoi familiari e caregiver: il carico assistenziale può condizionare in modo determinante la vita lavorativa e relazionale dell’intero nucleo familiare, incidendo sui costi sociali e sanitari nazionali.
Progressi e speranze future
Negli ultimi decenni, la diffusione delle Stroke Unit e il miglioramento delle terapie acute (come la trombolisi e la trombectomia meccanica nell’ictus ischemico) hanno contribuito a ridurre l’incidenza di disabilità grave e a diminuire la mortalità complessiva. Tuttavia, la prevenzione primaria (ovvero il controllo dei principali fattori di rischio come ipertensione, diabete, fumo, sedentarietà e fibrillazione atriale) resta la strategia più efficace per ridurre l’impatto dell’ictus sulla popolazione.
Le prospettive per il futuro riguardano il rafforzamento della rete di emergenza, la tempestività della diagnosi e la diffusione capillare dei programmi di riabilitazione personalizzata e di supporto psicologico, affinché la sopravvivenza all’ictus possa tradursi non solo in anni di vita ma soprattutto in qualità della vita.