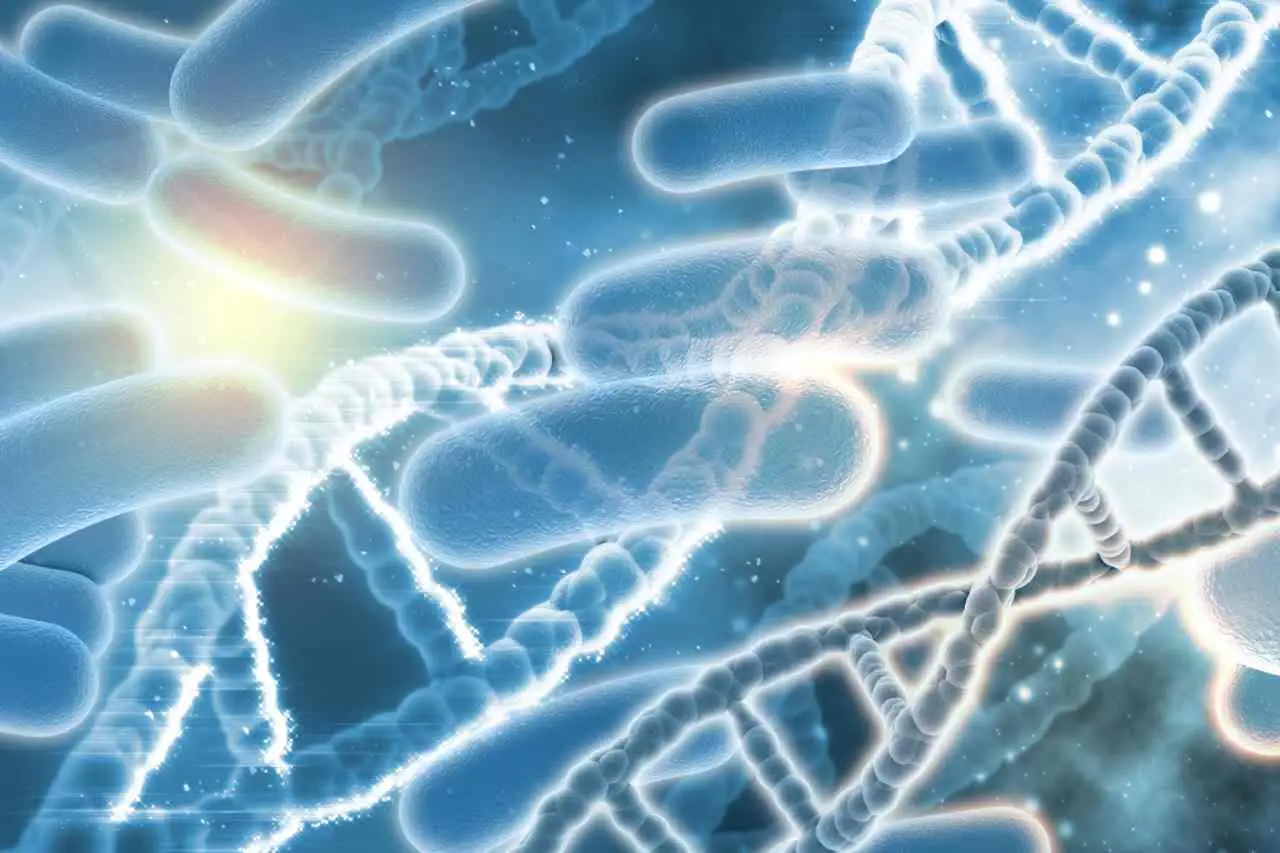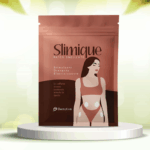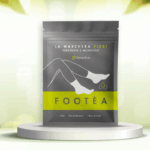La malattia di PolG rappresenta una delle forme più gravi e complesse tra i disturbi mitocondriali di origine genetica, tanto da allertare la comunità neurologica internazionale per la sua aggressività, l’eterogeneità clinica e la mancanza di terapie risolutive. Questo disturbo nasce da mutazioni del gene POLG, responsabile della codifica della DNA polimerasi gamma, l’enzima principale deputato alla replicazione e alla riparazione del DNA mitocondriale. Un malfunzionamento di questo gene innesca una catena di eventi che compromette in modo irreversibile il funzionamento dei mitocondri, le centrali energetiche delle cellule umane.
Caratteristiche genetiche e meccanismi patologici
Il gene POLG si trova sul cromosoma 15 (locus 15q24) e la sua funzione è strettamente collegata all’integrità del DNA mitocondriale. Le mutazioni del POLG compromettono la DNA polimerasi gamma-1, portando alla deplezione o instabilità del DNA mitocondriale: di conseguenza, i mitocondri perdono progressivamente la capacità di produrre energia (ATP) in modo efficiente. Il risultato è una insufficienza energetica cellulare che coinvolge più organi e tessuti ad alta richiesta energetica, come cervello, fegato, muscoli e nervi.
Le sindromi associate a mutazioni POLG sono incluse nel gruppo delle sindromi da deplezione del DNA mitocondriale (MDS o MDDS). Questi disordini sono quasi sempre a trasmissione autosomica recessiva; ciò significa che la patologia emerge solo se entrambe le copie del gene presentano mutazioni patogene. Stress ambientali ed epigenetici, come infezioni o l’uso di alcuni farmaci (in particolare acido valproico), possono accelerare l’insorgenza e l’aggravamento del quadro clinico.
Evoluzione clinica e sintomi neurologici
La presentazione clinica delle malattie causate da mutazioni in POLG è estremamente variabile, ma di norma l’esordio è infantile o adolescenziale, anche se esistono forme a insorgenza tardiva. Prima della comparsa dei sintomi, lo sviluppo psicomotorio e neurologico può apparire normale, rendendo difficile una diagnosi precoce. La gravità e la tipologia delle manifestazioni dipendono dall’età di esordio:
- Infanzia precoce (prima dei 12 anni): insorgono convulsioni, regressione delle capacità cognitive, disturbi motori, perdita della vista di origine corticale, difficoltà alimentari e danno epatico. Nel caso della sindrome di Alpers-Huttenlocher – la variante più nota della patologia – la combinazione di encefalopatia epilettica e disfunzione epatica è caratteristica e spesso fatale.
- Adolescenza e giovane adulto (tra 12 e 40 anni): si possono osservare crisi epilettiche, atassia (perdita di coordinazione dei movimenti), neuropatie periferiche e danno muscolare progressivo.
- Esordio adulto (oltre i 40 anni): prevalgono sintomi come ptosi palpebrale (abbassamento delle palpebre), oftalmoplegia (paralisi dei muscoli oculari), atassia, miopatia e quadri di parkinsonismo.
Un elemento clinico ricorrente è l’encefalopatia con crisi epilettiche resistenti alla terapia, spesso evolutive verso lo stato epilettico o l’epilessia parziale continua. Nelle fasi avanzate è tipica anche l’atrofia cerebrale diffusa e la perdita neuronale, evidenziata dalle indagini di neuroimmagine.
Implicazioni sistemiche e gestione clinica
La malattia di PolG è una patologia multisistemica, in cui gli organi maggiormente colpiti, oltre al sistema nervoso centrale, sono il fegato e il muscolo scheletrico. Nei casi pediatrici, può manifestarsi una epatopatia rapidamente progressiva che, insieme all’encefalopatia epilettica, determina una prognosi infausta in breve tempo. Nei pazienti con esordio più tardivo, prevalgono problemi muscolari (debolezza, intolleranza allo sforzo, crampi), neuropatie periferiche (formicolii, perdita di sensibilità, dolore) e alterazioni visive.
La diagnosi richiede un approccio integrato e multidisciplinare: si parte dall’osservazione clinica, con particolare riferimento ai disturbi neurologici ed epatici, e si prosegue con esami strumentali (elettroencefalogramma, risonanza magnetica) che documentano la perdita neuronale e l’atrofia cerebrale diffusa. I bassi livelli di mtDNA rilevati nei tessuti (fegato, muscoli) e la conferma di mutazioni attraverso analisi molecolari sul gene POLG sono elementi dirimenti.
Prognosi e approccio terapeutico
La prognosi è generalmente infausta, soprattutto nelle forme a insorgenza pediatrica, dove l’aspettativa di vita è spesso inferiore ai dieci anni. Le varianti ad esordio più tardivo consentono una sopravvivenza maggiore ma con progressiva disabilità neurologica e motoria. Ad oggi non esistono cure risolutive: la terapia è esclusivamente sintomatica e include il controllo delle crisi epilettiche, il supporto nutrizionale, la fisioterapia per mantenere la funzione muscolare e la gestione delle complicanze epatiche.
È fondamentale evitare l’impiego di alcuni farmaci neurotossici (acido valproico) che possono accelerare il peggioramento delle funzioni epatiche e del quadro clinico complessivo. Recenti tentativi sperimentali su piccola scala hanno suggerito la possibilità di alleviare alcuni sintomi con terapie coadiuvanti (antiossidanti, integratori di vitamine del gruppo B), ma i risultati non sono ancora conclusivi.
Impatto sociale e ricerca futura
La crescente attenzione da parte dei neurologi verso la malattia di PolG si spiega con la difficoltà diagnostica, la variabilità dei quadri clinici e la drammaticità del decorso. I casi che emergono spesso riguardano bambini e giovani adulti, determinando un impatto emotivo e sociale notevole su famiglie che si trovano a gestire pazienti con disabilità grave e progressiva. Vi è inoltre l’evidente necessità di migliorare la conoscenza genetica e potenziare la diagnosi precoce, anche nell’ambito delle indagini familiari e dei programmi di consulenza genetica.
La ricerca si sta concentrando sulla messa a punto di strategie di terapia genica mirate a correggere il difetto di POLG e restituire funzionalità ai mitocondri. Tuttavia, la complessa biologia mitocondriale e la difficoltà di raggiungere efficacemente tutti i tessuti colpiti rappresentano ostacoli ancora insuperati. Parallelamente si cercano marker biologici affidabili per una diagnosi rapida e non invasiva, e si promuove la creazione di reti internazionali per facilitare la raccolta dati e lo sviluppo di trial clinici collaborativi.
Le malattie genetiche mitocondriali, tra cui quelle legate a POLG, rappresentano una delle ultime frontiere della neurologia molecolare e della medicina di precisione. L’attenzione mediatica e il coinvolgimento di associazioni scientifiche e pazienti hanno dato maggiore visibilità e accelerato lo sviluppo della ricerca, nella speranza di trasformare una diagnosi oggi spesso fatale in una patologia gestibile e, un domani, potenzialmente curabile.